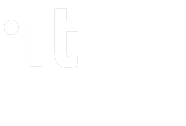Fagaceae
FAMIGLIA FAGACEAE
Questa Famiglia è costituita da piante legnose (alberi e più raramente arbusti) distribuite soprattutto nelle aree temperate e tropicali dell’emisfero boreale; sono riunite in 8 generi e in più di 950 specie. Si presentano con foglie alterne, semplici, picciolate ed a stipole presto caduche; i fiori, monoici, con perianzio a 4-7 tepali più o meno saldati fra loro: i maschili hanno da 4 a 20 stami (spesso il doppio dei tepali) e sono riuniti generalmente in amenti penduli, i femminili sono dotati di 3 (6) carpelli e si presentano singoli o a 2-5; il frutto è un achenio indeiscente, per lo più ad un solo seme e avvolto in un involucro di aspetto vario.
N.B.: Questa famiglia presenta specie importanti per l’alimentazione dell’uomo (soprattutto il castagno) e degli animali, e per la produzione di legno da ardere o da "costruzione".
Il genere Castanea,
è distribuito nelle aree temperate e calde dell'emisfero boreale ed è costituito da una decina di specie (1 in Italia). All'interno della Famiglia le sue specie si caratterizzano per le foglie dentate e con 13-20 paia di nervature secondarie, i fiori maschili riuniti in amenti allungati ed eretti nella parte inferiore e il frutto globoso-allargato (la castagna), circondato completamente da una struttura spinosa assai pungente (il riccio).
-Castanea sativa Mill. CASTAGNO
P scap – SE-Europ. - V – Comune.
Albero caducifoglio, alto da 5 a 25 m, eretto e a chioma espansa; le foglie sono semplici, dentellate e di forma oblungo-lanceolata (10-20 x 4-8 cm), picciolate e alterne, con una decina di paia di nervature secondarie; i fiori sono unisessuali e piccoli: i maschili sono riuniti in amenti eretti di 10-20 cm; alla base di questi originano quelli femminili in numero di 1-3; il frutto è avvolto da una struttura (il riccio) spinosa, rotondeggiante (6-7 cm di dimetro) che si fende alla maturazione facendo uscire le castagne (acheni) a guscio (pericarpo) liscio, coriaceo e marrone, che ricopre l’endocarpo bianco, avvolto da una sottile pellicola.
Habitat: boschi di collina e media montagna (200-800 m) su terreno acido.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Gestri & Biagioli 1992; Biagioli & Gestri 1993; Arrigoni & Menicagli 1999: Vernio, Cantagallo; Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002, Arrigoni & al. 2005, Bettini & al. 2009: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; Gestri 2018: Vernio, Cantagallo.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998 e Biagioli & al. 1999 (sub Castagno): Ampil del Monteferrato.
- Montalbano: Arrigoni & Menicagli 1999: Carmignano; Arrigoni & Viciani 2001 e Viciani 2001: R. Fornia (Carmignano); Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936, Ricceri 1993; Biagioli & al. 2002: ...mancano vere e proprie formazioni a castagneto ceduo...gruppi di individui sono presenti nelle aree marginali in particolare sul versante boscoso verso Bagnolo.
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S).
- Rilievi di Montemurlo: Arrigoni & Menicagli 1999.
- Rilievi di Vaiano: Arrigoni & Menicagli 1999.
N.B.: Normalmente in Toscana è presente in montagna al di sopra dei 200-300 m. Pur essendo uno fra i principali costituenti dei nostri boschi, probabilmente non si tratta di entità indigena: fu anticamente introdotto in Italia dall’uomo, soprattutto per il suo frutto, un tempo utilissima fonte di nutrimento per intere generazioni.
Il genere Fagus
distribuito nelle aree temperate dell'emisfero boreale conta una decina di specie (1 in Italia). All'interno della Famiglia le sue specie si si caratterizzano per: le foglie intere, ellittiche e non più lunghe di 7 cm, i fiori maschili riuniti in amenti posti all'ascella fogliare, di forma ovato-globosa e pendenti e per i frutti a 3 angoli acuti, contenuti in un involucro coperto di spine molli, che si apre in 4 valve.
-Fagus sylvatica L. FAGGIO
P scap – C-Europ. - V – Comune sopra una certa altitudine e in ambienti mesofili.
Albero di altezza compresa fra i 10 e i 35-40 m, con tronco regolare ed eretto e chioma tendenzialmente conica; la corteccia è liscia e grigiastra; le foglie, con picciolo di 1 cm o poco più, hanno lamina ellittica, lunga 6-7 cm, a margine intero o ampiamente crenulato e apice ottuso; le gemme sono fusiformi; i fiori unisessuali sono piccoli: i maschili riuniti in amenti ascellari di 1,5-2 cm, peduncolati, e i femminili, in numero di 2-3, in amenti eretti dotati di breve peduncolo; il frutto (la faggiola, edibile) è una noce di ca. di 8 X 20 mm, racchiusa in una cupola legnosa a 4 valve, ricoperta da aculei erbacei poco pungenti.
Habitat: da noi in boschi di altitudini superiori ai 700-800 o in ambienti mesofili.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Gestri & Biagioli 1992; Biagioli & Gestri 1993; Arrigoni & Menicagli 1999: Vernio, Cantagallo; Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002, Arrigoni & al. 2005, Bettini & al. 2009: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale; Foggi & Venturi 2009: Rio Trogola a S di Luogomano e Alta val di Carigiola; Gestri 2018: Vernio, Cantagallo.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub F. s. v. sanguinea), Gestri & Peruzzi 2013a e Gestri & Lazzeri 2021: di introduzione antropica.
- Calvana: Ricceri 1999; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Capanne di Savignano (Vaiano).
- Cascine di Tavola: Cenni 1990; Boretti & al. 2005-06 (sub Faggio): un solo esemplare al bosco delle Pavoniere (introdotto); Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998 e Biagioli & al. 1999 (sub Faggio): Ampil del Monteferrato.
- Monteferrato: Ricceri 1993. Pianura: Maugini 1946 (sub F. s. v. sanguinea): bosco della Villa di P. a Caiano. Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (S) (sub F. s. L. subsp. sylvatica): vers. NE in castagneto (sopra Serilli).
- Rilievi di Montemurlo: Arrigoni & Menicagli 1999.
- Rilievi a W di Vaiano: Arrigoni & Menicagli 1999.
P.S.: le faggiole sono commestibili, basta trattarle con il calore (tostate, lessate) in modo da eliminare alcuni principi tossici presenti a crudo. Un tempo da queste veniva prodotto un olio utilizzato anche a fini alimentari.
Il genere Quercus
ha distribuzione olartica e conta ca. 400 entità specie (10 specie autoctone - con alcune sottospecie-, 1 ibrido, 1 criptogenica e 4 esotiche). E' rappresentato da alberi (raramente arbusti) sempreverdi o a foglie caduche, o semipersistenti; foglie dentate, sinuate o intere; fiori maschili riuniti in amenti gracili, filiformi e pendenti e i femminili solitari in un involucro a piccole scaglie embricate; il frutto (la ghianda) ovale o oblungo, apicolato e a pericarpo coriaceo, è racchiuso in alto in una cupola a scagliette embricate.
-Quercus cerris L. CERRO
P scap – N-Euro-Medit. - IV-V – Comune.
Albero caducifoglio alto fino a 35 m, a corteccia che si screpola longitudinalmente lasciando intravedere un fondo rosso; le foglie sono alterne, picciolate (picciolo di 8-15 mm), ruvide su entrambe le facce, a contorno oblungo o ovale, e profondamente sinuate (incise fino a metà lamina o più in 4-9 paia di lobi); amenti maschili lassi; la ghianda, ovoide, ha un breve peduncolo, lungo ca. 3 cm e una caratteristica cupola con lunghe (fino a 1 cm) squame lineari eretto-patenti che la ricoprono (in forma di “parrucca ricciuta”).
Habitat: boschi di preferenza su substrato subacido.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959: Pian della Rasa; Gioffredi 1960: Limentra orientale; Gestri & Biagioli 1992; Biagioli & Gestri 1993; Arrigoni & Menicagli 1999: Vernio, Cantagallo; Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002, Arrigoni & al. 2005 e Bettini & al. 2009: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale;
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Gestri & Biagioli 1992; Biagioli & Gestri 1993; Arrigoni & Bartolini 1997; Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo; oss. Pinzani 2021 Wikiplantbase#Toscana: tra Centopini e i Bifolchi (Prato).
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998 e Biagioli & al. 1999 (sub Cerro): Ampil del Monteferrato.
- Montalbano: Arrigoni & Menicagli 1999: Carmignano; Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano; oss. Peruzzi 2018 Wikiplantbase#Toscana: a N del Pinone (Carmignano).
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936; Corti 1975; Biagioli & al. 2002: raro nelle aree boscate marginali; alcuni grandi esemplari sul sentiero dei Patriarchi (Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Biagioli 1992 e Biagioli & Gestri 1993 (M. Le Coste); Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Poggio a Caiano: Maugini 1946: Poggio del Cerreto (a W del Barghetto).
- Rilievi di Montemurlo: Arrigoni & Menicagli 1999.
- Rilievi di Vaiano: Arrigoni & Menicagli 1999.
-Quercus ×crenata Lam. PSEUDOSUGHERA
P scap – N-Medit. - III-IV – Rara.
Di questo albero si incontrano spesso 2-3 piante vicine, più difficilmente esemplari isolati. Si presenta a fusto eretto, dotato di corteccia un po' sugherosa, alto 5-25 m; stipole e segmenti esterni dei germogli quasi lineari; foglie persistenti, alterne, con picciolo di 5-10 mm, ovato-ellittiche (le maggiori di 2 x 4-5 cm) da subtroncate a cuneiforme in basso, coriacee, ruvide, pubescenti, verde-scuro di sopra e biancastre di sotto, profondamente crenate con mucrone terminale; ghiande brevemente peduncolate, ovate, larghe, compresa la cupola, 1,5-2,5 cm, quest'ultima appare tomentosa e grigiastra con scaglie molli, strette, erette o retroverse. Molto probabilmente si tratta di un ibrido: Q. cerris X Q. suber.
Habitat: radure, margini boschivi.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Ricceri 1999; Gestri 2009: presso Rimaggio (Vaiano); Gestri & Peruzzi 2016: da C. Bastone a La Pozza (Prato); presso Rimaggio (Vaiano).
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998 e Biagioli & al. 1999 (sub Cerro-sughera): Ampil del Monteferrato; Ricceri 2006 e Foggi & Venturi 2006: ambienti collinari e di media montagna fino a 800 m.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: sotto Pietramarina … e sopra S. Martino in Campo (Carmignano).
- Monte Le Coste: Gestri & Peruzzi 2013b (C): vers. S (rr.).
??-Quercus dalechampii Ten.
Indicata in Biagioli & al. 1999 per l'AMPIL del Monteferrato ha attualmente perso la propria individualità specifica ed è inclusa in Quercus pubescens Willd.
-Quercus ilex L. LECCIO P scap (P caesp) – Medit. - IV-VI – Comune.
Albero sempreverde, alto da 1 a 25 m, a gemme e giovani rami tomentosi; foglie di 3-7 cm, coriacee, a lamina ovale e margine intero o dentellato, con picciolo di 6-15 mm, biancastre di sotto e verde scuro ± brillante di sopra, il nervo centrale è diritto (non un po' sinuoso come in Q. suber); amenti maschili pubescenti ed allungati; la ghianda subsessile, ovale o conica, lunga fino a 1-3 cm, è ricoperta in alto da una cupola emisferica a brevi scaglie grigiastre appressate.
Habitat: boschi mediterranei e submediterranei, macchie.
Distribuzione sul territorio:
- Appennino principale pratese: Arrigoni & al. 2001, Arrigoni & al. 2002, Arrigoni & al. 2005 e Bettini & al. 2009: riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006: Limentra orientale;
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946; Gestri & Lazzeri 2021.
- Calvana: Fiori 1914; Gestri 2009; Gestri & Peruzzi 2016 (sub Q. i. L. subsp. ilex): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Cascine di Tavola: Cenni 1990; Boretti & al. 2006: Bosco delle Pavoniere; Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Leccio): Ampil del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Biagioli 1992, Biagioli & Gestri 1993; Arrigoni & Viciani 2001 e Viciani 2001: Fornia; Foggi & Venturi 2001: Carmignano; Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano; oss. Roma-Marzio 2017 Wikiplantbase#Toscana: lungo la via Madonna Madonna del Papa, dopo Bruceto (Carmignano).
- Monteferrato: Fiori 1914; Messeri 1936; Corti 1975; Ricceri 1993; Biagioli & al. 2001: la quercia più diffusa nell'area ofiolitica... (Prato, Montemurlo).
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 201b (sub Q. i. L. subsp. ilex) (C/S).
N.B.: la specie è presente anche sui rilievi di Montemurlo e a W di Vaiano, oltre che in alcune aree di pianura (spesso di introduzione antropica).
-Quercus petraea (Matt.) Liebl. ROVERE
P scap (P caesp) – Europ. (Subatl.) - IV-V – Non molto comune.
Albero caducifoglio, alto da 1 a 40 m, con corteccia inizialmente liscia e verdastra in seguito grigiastra e fessurata longitudinalmente, ma non profondamente; giovani rami glabri (in Q. pubescens pubescenti!) e verdastri; gemme ovate o coniche e raggruppate all'estremità dei rami, un po' pelose solamente sul margine delle scaglie; foglie opache, alterne, glabre, con picciolo scanalato di ca. 1-2 cm, a base conica e lamina a contorno ovato (larghezza massima verso la metà) di 4-7 X 8-11 cm, con 7-12 lobi poco profondi e ottusi all'apice; fiori unisessuali e regolari: i maschili riuniti in lunghi amenti e i femminili a 2-5 all'ascella delle foglie dei rami dell'annata; ghianda lunga 1-2 cm, sessile, con cupola a squame lanceolate ed embricate.
Habitat: boschi soprattutto a substrato acido.
Distribuzione sul territorio:
- Calvana: Fiori 1914 (sub Q. sessiliflora); Gestri 2009 e Gestri & Peruzzi 2016 (sub Q. p. (Matt.) Liebl. subsp. petraea): Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Biagioli & al. 1999 (sub Rovere): Ampil del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano; P. a Caiano.
- Monteferrato: Fiori 1914(sub Q. sessiliflora); Messeri 1936 (sub Q. sessiliflora Salisb.); Biagioli & al. 2002: ...presso Villa Ciabatti (Prato) … bosco dei Patriarchi (Montemurlo)...
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
-Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens ROVERELLA
P scap (P caesp) – SE-Europ. (subpontica) – IV-V – Comunissima.
Albero alto 10-25 m, a corteccia screpolata, nerastra e a solchi profondi; foglie caduche (ma persistenti a lungo sui rami in inverno) con rametti giovani (grigiastri) e gemme (brune e ovoidi) pubescenti-biancastre (questo è uno dei caratteri principali che lo distingue da Q. petrae); foglie alterne, con peduncoli di 5-12 mm, sinuato-lobate, finemente pubescenti di sotto e lunghe fino a 7-10 cm; fiori unisessuali: i maschili riuniti in amenti lassi e pendenti, i femminili assai piccoli e terminali; la ghianda è sessile o con breve peduncolo (inferiore al picciolo), ovoide con cupola emisferica ricoperta da scaglie lanceolate, simili fra loro e embricate con superficie quasi liscia, le superiori a punta brevemente saliente.
Habitat: boschi con optimum in area submediterranea e su calcare.
- Appennino principale pratese: Porciatti 1959 (sub Q. lanuginosa): Pian della Rasa; Gioffredi 1960 (sub Q. lanuginosa): Limentra orientale; Arrigoni & Menicagli 1999 (sub Q. p. Willd. s.l.): Vernio, Cantagallo; Arrigoni & al. 2001 (sub Q. p. Willd. s.l.), Arrigoni & al. 2002 (sub Q. p. Willd. s.l.), Arrigoni & al. 2005 (sub Q. p. Willd. s.l.) e Bettini & al. 2009 (sub Q. p. Willd. s.l.): riserva naturale Acquerino-Cantagallo; Venturi 2006 (sub Q. p. Willd. s.l.): Limentra orientale.
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Q. lanuginosa); Gestri & Lazzeri 2021 (sub Q. p. Willd. s.l.).
- Calvana: Gestri & Biagioli 1992 (sub Q. p. Willd. s.l.); Biagioli & Gestri 1993 (sub Q. p. Willd. s.l.); Arrigoni & Bartolini 1997 (sub Q. p. Willd. s.l.); Gestri 2009 (sub Q. p. Willd. s.l.) e Gestri & Peruzzi 2016: Prato, Vaiano, Cantagallo.
- Localizzazioni generiche: Arrigoni & Menicagli 1999 (sub Q. p. Willd. s.l.): comune di Prato; Ricceri 1998 (sub Q. p. Willd. s.l.); Biagioli & al. 1999 (sub Roverella): Ampil del Monteferrato.
- Montalbano: Arrigoni & Menicagli 1999 (sub Q. p. Willd. s.l.): Carmignano; Gestri & Peruzzi 2013a (sub Q. p. Willd. s.l.): Carmignano; P. a Caiano.
- Monteferrato: Messeri 1936 (sub Q. robur L. var. lanuginosa Lam.); Corti 1975 (sub Q. p. Willd. s.l.); Arrigoni & al. 1979 (sub Q. p. Willd. s.l.); Ricceri 1993 (sub Q. p. Willd. s.l.); Biagioli & al. 2002 (sub Q. p. Willd. s.l.): presente, ma sporadica in tutta l'area...
- Monte Le Coste e Poggio alle Croci: Gestri & Biagioli 1992 (sub Q. p. Willd. s.l.) e Biagioli & Gestri 1993 (sub Q. p. Willd. s.l.): M. Le Coste; Gestri & Peruzzi 2013b (C/S).
- Pianura: nuovi ritrovamenti: alcune piante secolari a Gonfienti sull’argine del Bisenzio (1990) (Prato).
- Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Q. lanuginosa): Poggio del Cerreto.
- Rilievi di Montemurlo: Arrigoni & Menicagli 1999 (sub Q. p. Willd. s.l.); confermata la presenza diffusa a tutt'oggi!
- Rilievi di Vaiano: Arrigoni & Menicagli 1999 (sub Q. p. Willd. s.l.); confermata la presenza diffusa a tutt'oggi!
-Quercus robur L. FARNIA
P scap -Europ.-Caucas. - IV-V – Non rara in pianura.
Albero alto da 5 a 35 m, caducifoglio, a giovani rami glabri e flessibili, con corteccia a fessurazioni longitudinali, di colore bruno-grigiastro; foglie grandi, alterne, glabre e subsessili, obovato-oblunghe, lobate, auricolate in basso e ottuse in alto; le ghiande sono situate (1-4 distanziate) su lunghi peduncoli, sono oblunghe e ricoperte in alto da una cupola glabra e relativamente con poche scaglie concresciute e fortemente appressate.
Habitat: è specie tipica dei residui boschi planiziali, si può incontrare in ambienti a substrato neutro e falda freatica alta.
Distribuzione sul territorio:
- Bargo di Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Q. pedunculata); Gestri & Lazzeri 2021.
- Cascine di Tavola: Stampi 1967; Arrigoni 1990; Cenni 1990; Boretti & al. 2006: bosco delle Pavoniere; Foggi & Venturi 2009; Gestri & Lazzeri 2021.
- Localizzazioni generiche: Ricceri 2006: in pianura e risale lungo la valle del Bisenzio fino a Vernio; Biagioli & al. 1999 (sub Farnia): Ampil del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: P. a Caiano.
- Pianura: nuovi ritrovamenti: Galceti, Maliseti (2002) (Prato) ed in varie altre localizazioni...
- Poggio a Caiano: Maugini 1946 (sub Q. pedunculata): Poggio del Cerreto (a W del Barghetto).
-Quercus rubra L. QUERCIA ROSSA
P scap – Esotica coltivata e a volte naturalizzata di orig. N-Americ. - IV-V – Non molto comune.
Albero caducifloglio, alto 10-25 m, a scorza ± liscia e grigiastra, con giovani rami glabri e rossastri; le foglie alterne, di 8-12 X 12-17 cm e con picciuolo di 2-4 cm, si presentano di forma oblanceolata, profondamente lobate in 7-9 lobi dentellati acutamente al bordo; fiori maschili in lunghi amenti pendenti, i femminili molto piccoli e posti sui rigetti dell'annata; la ghianda è oblunga (larga fino a 2,5 cm), con cupola poco profonda, che copre meno del quarto superiore del frutto.
Habitat: parchi, margini stradali, boschi artificiali.
Distribuzione sul territorio:
Cascine di Tavola: Cenni 1990; Boretti & al. 2006: bosco delle Pavoniere; Foggi e Venturi 2009, Gestri & Lazzeri 2021.
N.B.: si incontra, coltivata con relativa frequenza, in vari parchi e giardini pubblici dei comuni della provincia di Prato.
P.S.: è albero spesso coltivato soprattutto per il bel colore purpureo che le foglie assumono in autunno.
-Quercus suber L. SUGHERA P scap – W-Medit. - IV-V – Abbastanza rara.
Albero alto 5-15 m, pseudosempreverde (nel senso che le foglie cadono a giugno mentre germogliano le nuove), a corteccia spessa a volte diversi cm (sugherosa); le foglie (simili a quelle del leccio) si presentano alterne, lanceolato-ellittiche, ± dentellate, lunghe 3-5 cm, coriacee, a 5-7 coppie di nervature laterali (quella centrale un po' sinuata), brevemente picciolate; ghiande di 2-3,5 x 1,2-1,8 cm, di forma allungata a punta breve, con cupola coprente ca. metà frutto, con scaglie un po' diverse fra loro (le superiori riflesse) e pubescenti.
Habitat: boschi assolati e aridi; da noi abbastanza spesso coltivata.
Distribuzione sul territorio:
- Localizzazioni generiche: Ricceri 1998; Biagioli & al. 1999 (sub Sughera): AMPIL del Monteferrato.
- Montalbano: Gestri & Peruzzi 2013a: Carmignano, P. a Caiano: a volte sembrano introdotte dall'uomo.
- ?Monteferrato: Ricceri 1993.
- Monte Le Coste: Tozzi 1998 (sub Sughera) e Gestri & Peruzzi 2013b (C): Natreta (Prato). Montemurlo pianura e rilievi: nuove osservazioni: sicuramente introdotte dall'uomo su via Montalese a E della cittadina e a margine della strada (via Freccioni) sotto il cimitero.